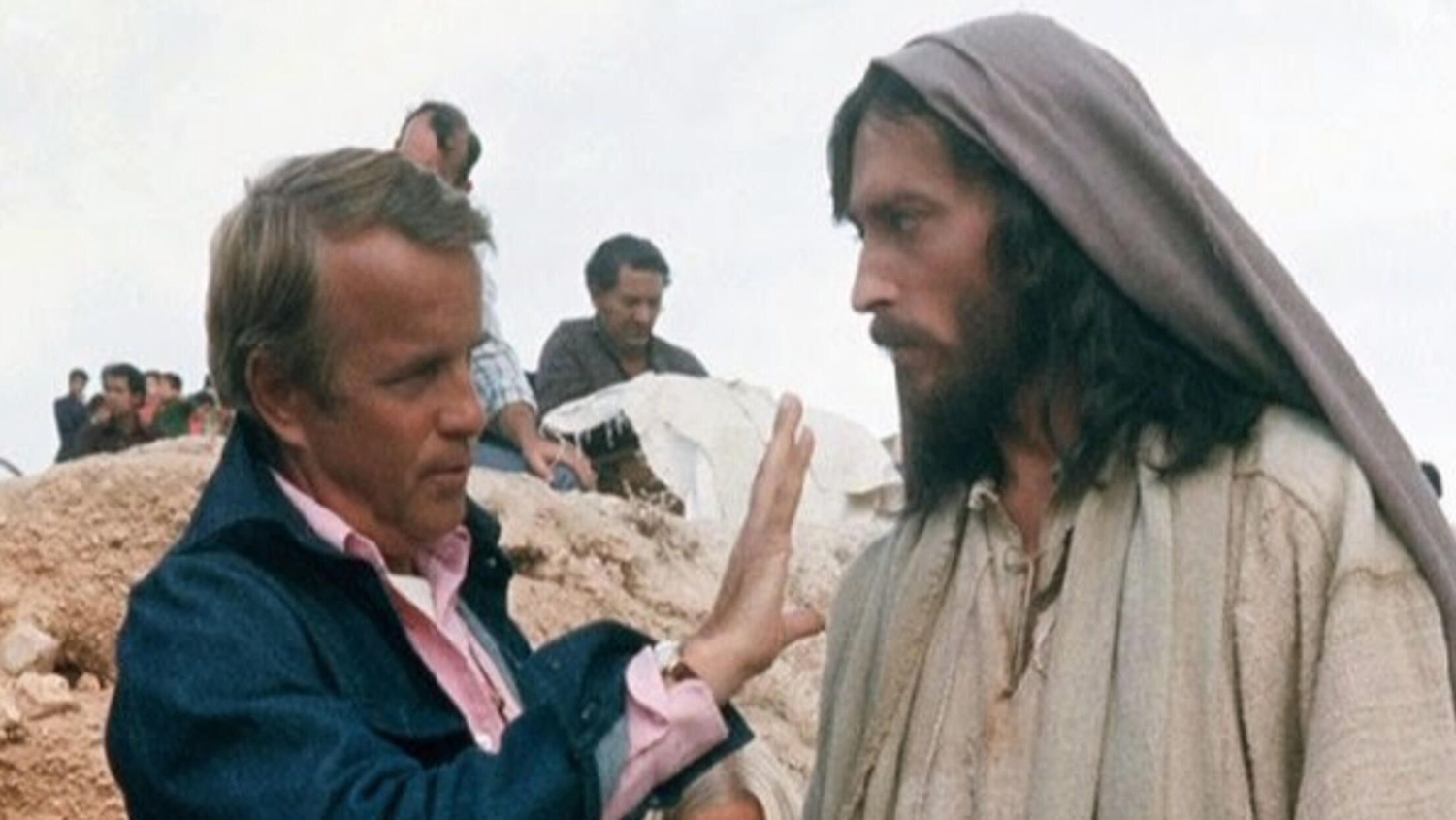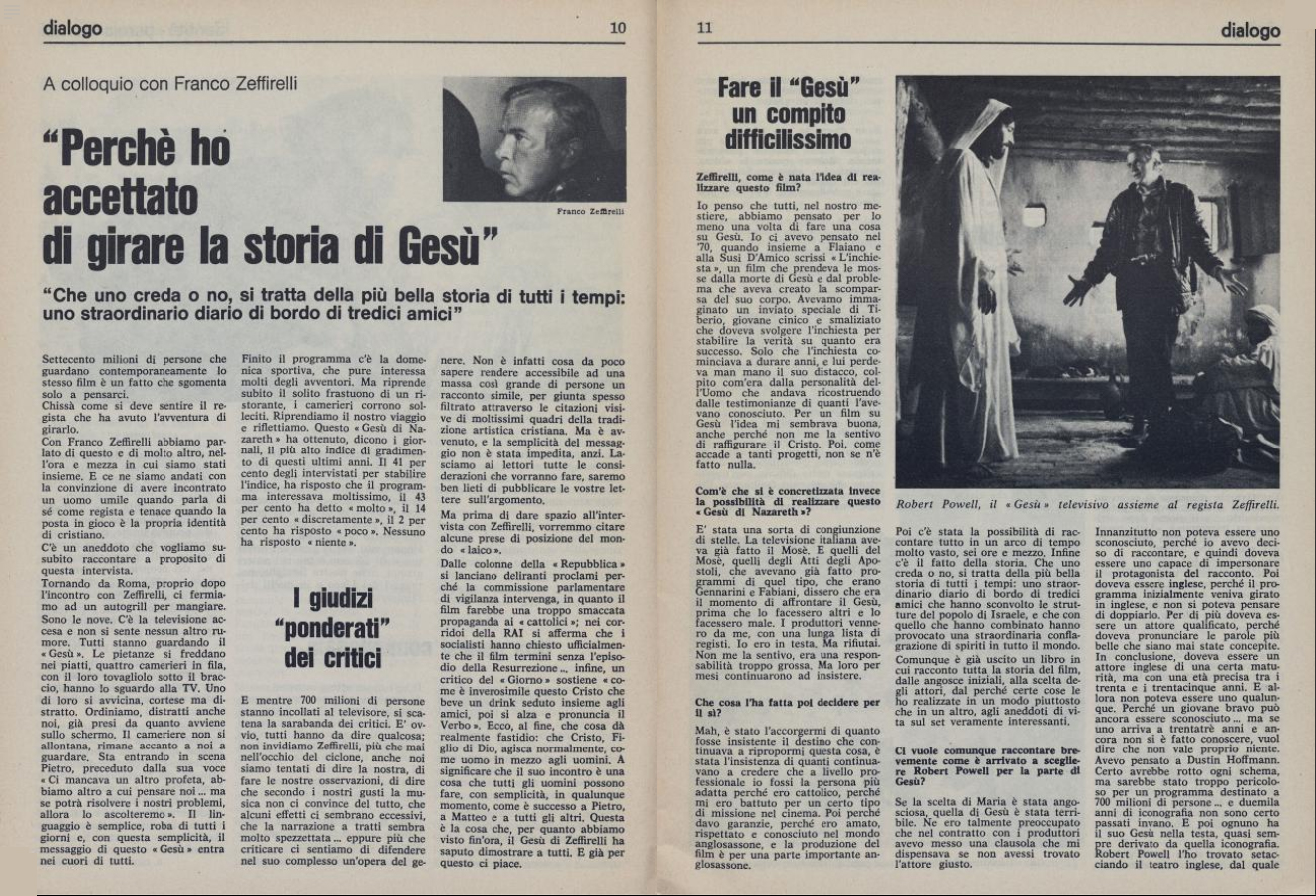Jesùs
Castellano Cervera
LETTURA TEOLOGICO SPIRITUALE
DELL'ICONA DELLA VERGINE DEL CARMINE
DETTA " LA BRUNA "
Maria SS. del Carmine Maggiore , detta " La Bruna " , Napoli
.
Leggere il
mistero di una icona veneratissima ed antica come quella della Madre di Dio,
detta la Bruna, che presiede la Chiesa del Carmine Maggiore di Napoli, è per me
un onore e una sfida. Prima di tutto è l'onore di un figlio carmelitano che
contempla una delle più antiche immagini di Maria che sono rapportate al titolo
di Madre del Carmelo. Una sfida perché tale lettura impegna la mente ed il cuore
nello svelamento dei misteri che ogni immagine sacra porta con sé, in maniera
oggettiva, al di là dei nostri sentimenti e dei nostri gusti. Cercherò quindi di
leggere quest'immagine, non dal punto di vista storico o devozionale , ma dal
punto di vista teologico e spirituale, a partire da una convinzione, che si è
fatta certezza, dopo aver contemplato l'immagine restaurata della Bruna, prima
nelle riproduzioni recenti e poi direttamente a faccia a faccia. È la certezza
di trovarci davanti ad un'icona della Madre di Dio, di ispirazione certamente
orientale, alla quale è doveroso applicare per analogia, quanto si può dire
delle icone orientali della Madre del Signore. Esordirò quindi con alcune
annotazioni di carattere generale sull'icona per poi fissare l'attenzione
nell'immagine della Bruna di Napoli.
1. L'ICONA: IL MISTERO DI UNA PRESENZA
L'icona è
un segno sacramentale della Chiesa. Questa sacramentalità è molto accentuata in
Oriente fino ad affermare che le immagini sacre sono come "presenze" delle
persone e dei misteri che rappresentano. La " sacramentalità " delle icone forse
in principio non veniva direttamente da una speciale benedizione impartita dalla
Chiesa, ma semplicemente dal contatto vivo delle icone stesse con la liturgia
celebrata, con la fede confessata e la preghiera ecclesiale; o proveniva dalla
sacralità del luogo dove era celebrata l'Eucaristia ed era presente l'icona.
Oggi esiste in Oriente un rito speciale per la benedizione delle icone; non
manca un analogo rito di benedizione delle immagini neppure in Occidente.
Tuttavia in alcuni luoghi di Oriente Je icone sono benedette quasi per contatto
con il mistero eucaristico, passandole sopra la patena ed il calice prima della
dossologia dell'anafora. L'icona entra così a far parte dell'universo simbolico
della liturgia, con il carattere evocativo di una presenza e per essere la
visibilità dell'invisibile volto di Cristo, di Maria e dei Santi; esse irradiano
uno sguardo amico, offrono una compagnia che, nel mistero della comunione dei
Santi, ci viene incontro e da noi è confessata ed invocata. . , ,, Con questa
benedizione la Chiesa esprime un duplice sentimento della propria fede: rendere
l'immagine un segno sacro, evocativo per la fede dei fedeli della realtà che
rappresenta; invitare i fedeli a venerare le persone o i misteri rappresentati.
. Davanti ai nostri occhi l'immagine è come una presenza che si propone come una
finestra aperta sul mistero per poter entrare m comunione con Cristo, con la
Madre di Dio e con i Santi; una presenza accessibile che ci invita anche
all'imitazione, a realizzare nella nostra vita ciò che vediamo, a riviverlo
interiormente. L'immagine è un ricordo/memoriale, luogo d'incontro di sguardi e
di presenze; è possibilità di contemplazione, è stimolo all'imitazione. Nel a
preghiera davanti a un'immagine di Cristo o della Vergine Maria, non solo
guardiamo ma ci sentiamo anche guardati da Qualcuno/a che ci ama. La
contemplazione è in questo caso un modo di "contemplare 1 Inviabile. (Cfr Eb 11
27) o, come dice la liturgia di Natale, una visione della realta soprannaturale,
"affinchè contemplando le cose visibilmente siamo portati all'amore
dell'invisibile". . Il Patriarca Dimitrios I esprimeva così nel 1987, nella sua
Enciclica sulle sante icone, il senso profondo dell'icona di Cristo come
manifestazione della sua presenza, secondo la più genuina tradizione orientale.
Ma il testo può essere anche riferito alla Vergine Maria: "L'icona di Cristo
testimonia una presenza, la sua stessa presenza, che consente di giungere ad una
comunione di partecipazione, ad una comunione di preghiera e di resurrezione, ad
una comunione spirituale, ad un incontro mistico col Signore dipinto in
immagine. Certamente l'icona del Signore non e Cristo stesso, come
nell'Eucaristia il pane è il suo corpo e il vino il suo Sangue.
Nell'icona c'è la presenza della sua ipostasi, che non cambia ne modifica m
nulla la materia o i colori o il pennello o i disegni esteriori e le forme alle
quali i disegni corrispondono. Tuttavia, questa icona riproduce in maniera
ipostatica (personale) le sembianze e l'identità di Cristo, che in essa è
raffigurato con quanto è caratteristico di tutta la sua immagine. Tutto il
mistero dell icona e contenuto in queste sembianze dinamiche e misteriose che
rinviano ali originale, vale a dire all'essere divino e umano del Signore".'
--Testo
dell'Enciclica del Patriarca Dimitrios in 11 Regno /Documenta 1 marzo
1988 pp 148-156, testo citato a p. 154; Per una introduzione alla comprensione
delle
icone Sella Madre di Dio, cfr. SUOR MARIA DONADEO, Icone dola Madre d^o_
Broscia, Morcelliana, 1982. Una breve presentazione delle icone ir.Catecheo
della chiesa
cattolica, nn. 1159-1162; cfr. anche il mio contributo: Icone, m Dwonano
Enciclopedico
di Spiritualità. Roma, Città Nuova, 1990, pp. 1241-1251.
Ci sono
poi, in Oriente ed in Occidente, immagini che cariche della preghiera e della
venerazione dei fedeli diventano come un luogo di rivelazione, una presenza
miracolosa. Questo inserimento delle icone nel movimento cultuale della Chiesa,
ascendente e discendente, quale presenza di grazia e luogo di preghiera, le
rende particolarmente adatte ad essere una mediazione per l'incontro con il
mistero, nella linea della sacramentalità della Chiesa e della santa liturgia,
con il senso positivo di manifestazione visibile delle cose invisibili, con la
capacità di suscitare la fede e l'amore senza i quali non si entra in comunione
con il mistero. Diventano così luogo dell'incontro delle persone, trasparenza
per un rapporto di comunione spirituale fra il credente che vi si accosta con la
propria fede e le persone rappresentate che in qualche modo rendono visibile il
loro rapporto vivo con noi nella comunione dei Santi. In sintesi, ogni icona,
per poter essere venerata dai fedeli, deve possedere tré qualità che solo la
Chiesa può garantire e che sono interpretate dalla tradizione con un senso molto
preciso. Deve essere quindi un'immagine vera, miracolosa e a-cheròpita. Vera, in
quanto i suoi tratti devono corrispondere esattamente alla parola che la
illumina e che l'immagine stessa rende visibile, al mistero che rappresenta.
Miracolosa, in quanto fa vedere le meraviglie di Dio, per quanto a volte si
tratta anche di un'immagine che possiede la qualità carismatica di essere una
fonte di grazie soprannaturali e di manifestazioni miracolose. Acheròpita, in
quanto non deve corrispondere ad un'opera semplicemente umana, fatta da mano
d'uomo, ma in qualche modo deve essere un'immagine "non fatta da mano d'uomo",
ispirata da Dio attraverso la mediazione della sua parola e la tradizione della
Chiesa. Tale è per noi l'immagine santa e santifìcatrice della Vergine Maria,
Madre di Dio, Vergine del Carmelo, la Bruna di Napoli, attraverso il flusso di
grazia e di devozione che unisce il suo sguardo allo sguardo e alla preghiera
dei fedeli. La Vergine del Carmelo a Napoli è anche tutto questo: una presenza
sacramentale di Maria in una sua icona, una finestra che apre il cielo alla
terra e la terra al cielo.
2.
L'ICONA DELLA BRUNA FRA LE ICONE TRADIZIONALI DELLA VERGINE MARIA
Le
immagini della Vergine Madre di Dio sono innumerevoli. Sono tutte
rappresentazioni della Vergine Maria nei suoi episodi evangelici e nei suoi
titoli teologici. Ma vi sono innumerevoli icone che hanno origine da
un'apparizione, da un miracolo, dalla venerazione tributata in un determinato
santuario. Segnaliamo per prime alcune immagini classiche. La rappresentazione
più comune è quella dell'immagine della Theotòkos Madre di Dio col Bambino Gesù
fra le sue braccia o nel suo seno. Tale immagine ha diversi nomi teologici, sia
per l'espressione del suo volto che per il rapporto della Madre con il Bambino
che tiene fra le braccia. Tutte però hanno in comune il titolo più eccelso della
Vergine Maria: Madre di Dio. Il titolo che tutto contiene, la sintesi della
vocazione e de missione di Maria, il principio da cui scaturiscono tutti i suoi
privilegi. La Vergine viene rappresentata come Odighitria, colei che indica la
via, se ci presenta il suo Figlio Gesù ed indica che è Lui la via. La Vergine
Eleousa, o della tenerezza, esprime l'intimità della Vergine con il Bambino,
fusi in un abbraccio. Di questo tipo, come si dirà, è la Vergine Bruna, Madre di
Dio della tenerezza; si chiama anche Glycofìlousa, del dolce amore e dei dolci
baci, perché rappresenta la Vergine in un tenero bacio, o con le guance
accostate del Figlio e della Madre. La Vergine Galattotrefoussa rappresenta
Maria che nutre con il latte del suo seno il Bambino. Esiste anche un'immagine
di Maria in cui l'atteggiamento del Bambino è quello di un bimbo che giocherella
con la Madre in posizione ardite. Esiste pure il tipo della Vergine, detta
Kyriotissa, che forse significa anche Signora, perché sostiene il Bambino fra le
sue ginocchia, come seduto su un trono. La Vergine è chiamata Panaghia, o Tutta
Santa, perché è coperta da un manto rosso che indica la santità dello Spirito
Santo, ed esprime la pienezza della sua santità esteriore ed intcriore.
La Platytera, o più grande dei cieli, è colei che contiene l'Incontenibile, o
colei che è immensa a tal punto che contiene l'Immenso. La vergine Orante, con
le mani giunte in preghiera e il Bambino in un cerchio di gloria, come quella di
Jaroslav, o semplicemente con le mani alzate in preghiera come quella di Santa
Sofia di Kiev. La Vergine Psychosostria, o colei che salva le nostre anime. La
Vergine della Passione, conosciuta in Occidente come la Vergine del Perpetuo
Soccorso, con gli Angeli che recano gli strumenti della Passione e il Bambino
che guarda attonito verso il futuro che lo attende. Maria è come la Portaissa,
porta del cielo, dal nome di una delle icone più celebri del Monte Athos,
conservata nel monastero di Iviron. Con frequenza la Madonna è anche avvolta in
un manto rosso o porpora che ricopre pure il suo tipo; il colore rosso o porpora
indica la sua santità, e per questo la Vergine viene chiamata Panaghia (Tutta
santa), con una espressione cara ai fratelli di Oriente che sottolineano il suo
rapporto con il Panaghion o Tuttosanto (lo Spirito Santo) che avvolge
completamente Maria. Sulla veste di Maria sono dipinte tré stelle, alle volte è
visibile solo una, come nel caso della Bruna. Una sulla fronte, due ai lati,
formando un triangolo che allude senz'altro alla Trinità. Secondo
l'interpretazione più accettata si tratta di un segno che indica la triplice
verginità di Maria: prima, durante e dopo il parto. La Vergine Bruna è parte
integrante della grande tradizione pittorica che si ispira all'iconografia
orientale e per la sua antichità si colloca fra le più significative e più
antiche icone venerate in Occidente, se risale, come molti credono, alla seconda
metà del secolo XIII.2
Il suo tipo corrisponde a quello della Madre di Dio della tenerezza, Eleousa , o
la Vergine Glycofìlousa, dei dolci baci. La sua contiguità con le immagini
orientali è tale, che anche se fosse di origine italiana, una improbabile
Madonna senese, come alcuni ritengono, si tratta sempre di una immagine ispirata
all'iconografia dell'Oriente. Il fatto poi che vi sia nella tradizione della
Bruna di Napoli la sua commemorazione settimanale al mercoledì - i mercoledì
della Bruna - e non al sabato, anche se si tratta di una tradizione che risale
ad un particolare miracolo della Bruna, avvenuto in un mercoledì, suggerisce
ancora con più forza la contiguità della tradizione orientale di tale devozione.
Il mercoledì è ancora oggi il giorno del ricordo di Maria come Madre di Dio
nella liturgia bizantina.
3.
UNA LETTURA STORICA DELL'IMMAGINE DELLA BRUNA ALLA LUCE DELLA TRADIZIONE DEL
CARMELO
II
Carmelo, con le sue tipiche radici orientali, ha venerato fin dall'inizio della
sua esistenza la Madre di Dio nella piccola e bella cappella primitiva del primo
monastero del Wadi-ain- es-Siah, presso Haifa in Israele. Nessuna notizia
autorevole può appagare la nostra curiosità di sapere come era l'immagine di
Maria venerata dai primi Carmelitani. Si può logicamente supporre che si
trattasse di una icona, di una tavola dipinta, più che di una immagine in legno
o in marmo, e che raffigurasse il tipo classico
della Theotokos, la Madre di Dio, con il Bambino tra le braccia in quell'atteggiamento
di comunione e di tenerezza che è caratteristico di tante immagini venerate dai
Carmelitani, come nel caso della nostra icona della Bruna di Napoli o della
Madonna del Carmine di Firenze. Prima ancora che l'iconografia della Vergine del
Carmelo presenti i tratti caratteristici dello Scapolare, della protezione
sull'Ordine o della sollecita liberazione dal Purgatorio, i Carmelitani
riconoscono la loro Madre nel volto tenero e materno della Madre di Dio. 2 Per
le notizie storiche che riguardano la Bruna ed il suo culto cfr. G. MONACO, S.
Maria del Carmine detta " La Bruna ". Storia, culto, folklore, Napoli,
Laurenziana, 1975; La Vergine Bruna e il Carmine Maggiore di Napoli . Fede,
storia, arte. Napoli 1988. Forse una delle immagini più antiche della Vergine
del Carmelo è il ritratto conservato dell'icona della Madre di Dio venerata per
molto tempo nella chiesa di San Cassiano a Nicosia (Cipro), poi alla Basilica di
Santa Sofia, sempre a Nicosia, e ora nel Museo cittadino dedicato
all'Arcivescovo Makarios. Si tratta di una bella tavola a colori, verosimilmente
del secolo XIV, dovuta ali' arte di un iconografo orientale. La Vergine appare
maestosa, assisa in trono, ricoperta di un mantello bianco; porta alla sua
sinistra il Bambino e lo indica come Salvatore; ai suoi piedi si vede un gruppo
di Carmelitani che indossano il bianco mantello dell'Ordine, in atteggiamento di
supplica e di venerazione; ai lati, secondo lo stile dell'iconografìa orientale,
sedici scene che probabilmente si riferiscono alla storia dell'Ordine, ma,
purtroppo, indecifrabili, dato lo stato generale di deterioro della pittura.
Questa immagine combina tré tipi iconografici classici: la Theotokos (Madre di
Dio), la Odighitria (Colei che mostra la via, perché indica il suo Figlio come
Via), la Kyriotissa (Signora o Regina), per il suo atteggiamento maestoso in
quanto Maria diventa il trono stesso di Cristo). Si tratta di una icona
venerabile che è stata con tutta probabilità venerata dai Carmelitani di Cipro
quando nell'isola esisteva una Provincia Carmelitana (1291-1570) con ben sei
conventi, dei quali uno precisamente a Nicosia, da dove certamente proviene
l'immagine.3 Tuttavia, nonostante queste tracce di ispirazione orientale per
dipingere la Madre del Carmelo, è prevalso in Occidente il tipo primitivo della
Vergine Madre di Dio, come quella della Bruna, in quella raffigurazione che
rende presente la grande comunione della Vergine con il Figlio fino a presentare
i due con due guance accostate l'uno all'altra. Abbiamo così il tipo della
Vergine Eleousa, o della tenerezza, che diventa pure la Glycofiloussa (dei dolci
baci o del dolce amore). Sono stati conservati di quest'immagine alcuni tipi
iconografici della Vergine venerati dai Carmelitani, per sottolineare la vera
maternità di Maria e la vera umanità di Gesù, quando la dipingono allattando il
Bambino; questo tipo, che trova anche alcuni esemplari carmelitani, come quello
del Carmine di Catania, si chiama, come è stato ricordato, Galattotrefoussa
(Colei che nutre con il proprio latte). Questi tipi iconografici antichi, spesso
ritrovati nella raffigurazione primitiva della Madonna del Carmine, sono oggi di
nuovo riflessi in alcuni tentativi di iconografia carmelitana moderna. Essi
indicano l'essenziale della devozione mariana del Carmelo : la proclamazione
della Vergine quale 3 Sulla storia e l'arte in questa antica icona, con una
bella riproduzione dell'insieme e dei dettagli, cfr. R. PALAZZI, Sotto il manto
della Madre, in La Vergine Bruna, n. 7-8, luglio agosto 1989, pp. 24-29.vera
Madre di Dio e sempre Vergine, Immacolata e Purissima, piena della santità dello
Spirito. II Carmelo presenta così una congiunzione fra Oriente-Occidente nella
venerazione della Madre di Dio e diventa un segno di unità nella stessa tenera
venerazione dei fratelli cattolici ed ortodossi alla Vergine Maria. L'immagine
della Vergine Bruna di Napoli non si può capire se non a partire da questi dati
storici ed iconografici. Come l'immagine di Maria nella cappella del primitivo
monastero era la Signora del luogo e la sua presenza materna accompagnava la
vita dei primi Fratelli della B.V.M. del Monte Carmelo, così pure dovunque i
Carmelitani sono arrivati hanno portato con sé l'immagine di Maria, la loro
Signora del luogo e della comunità, la Madre e la Sorella. Forse è troppo
pensare che la Bruna sia la stessa immagine venerata in quella cappella del
Carmelo. Tuttavia essa rappresenta molto bene l'esenziale devozione primitiva e
la continuità di una pietà orientale. Anche nell'ipotesi di alcuni autori che
essa provenisse non dall'Oriente , ma dall'Italia, non dobbiamo dimenticare che
tutto il litorale dell'Adriatico e del Tirreno è costellato di presenze
iconografiche orientali. Ci troviamo quindi con un'immagine antica, forse della
seconda metà del tredicesimo secolo. Certamente di tratti orientali, ciprioti o
cretesi, comunque radicata nella tradizione iconografica orientale, come ci farà
capire anche una rapida lettura estetica e teologica dell'Icona. Vero è comunque
che l'immagine della Bruna ha avuto una grandissima fortuna iconografica oltre
che devozionale. Si tratta di una immagine che è stata moltiplicata in tante
creazioni originali. A Napoli doveva esserci una grande scuola di riproduzioni
dell'icona della Bruna. In una recente esposizione di antiche icone fatta in
quest'anno 2000 a Valencia, è stata portata una bellissima copia della Bruna,
che risale probabilmente al sec. XIV. Si trova nel paese de La Yesa, non lontano
dal mio paese natale, ed è una copia fedelissima della Bruna, anche perché
tradizionalmente porta il titolo di Madonna del Carmine. Probabilmente è stato
portata nel sec. XVI da un soldato che ha dimorato a Napoli e ha voluto regalare
quest'immagine alla sua parrocchia natale come un dono prezioso. E la si
conserva con il titolo di Madonna del Carmine. Sia Maria, sia il Figlio sono
incoronati, secondo la tradizione occidentale.
4. UNA CONTEMPLAZIONE ESTETICA
Sono molti gli elementi di carattere estetico che ci aiutano a decifrare il
significato profondo dell'icona della Bruna. 4 Oriente en Occidente. Antiguos
iconos valencianos, Valencia 2000, pp. 34.179, 224.P. II primo elemento che
richiama la nostra attenzione è il fondo d'oro in cui s'iscrive l'icona. Questo
sfondo dorato dell'icona, detto luce, esprime il fatto che l'icona è nella luce
del mistero di Dio. Anche la progressiva chiarezza data all'icona con ocra
giallo è chiamata luce. Dipingere un'icona significa illuminare o "scrivere" un
volto o un mistero. Maria e la sua maternità divina, illuminata dallo sfondo
dorato dell'immagine, sono iscritte nel mistero di Dio. Ma questa luce dorata,
divinizzante, è presente anche in altri dettagli dell'icona. E evidente nel
fregio dorato del bordo del vestito della Madre di Dio, nella stella che porta
all'altezza delle spalle a destra. Quest'oro diventa quasi impercettibile e pure
scintillante nelle pennellate dorate sul rosso del copricapo o piuttosto una
cuffia rossa all'intemo del capo della Vergine, nelle sue eleganti maniche e nel
vestito del Bambino. Questo particolare iconografico delle pennellate dorate che
rendono scintillanti le vesti, è chiamato assist. Questa forma spesso attribuita
a Teofane il Greco, pittore di icone del XIV secolo, esprime con leggere
pennellate d'oro sulle vesti di Cristo, della Vergine e dei Santi, oltre ad una
particolare leggerezza e bellezza, la trasfigurazione delle persone mediante
l'elemento divino, l'oro, la luce, che penetra la figura e le vesti. Ciò indica
che le persone sono come divinizzate, partecipi della luce di Dio, della sua
natura. L'immagine di Maria, oltre ad essere iscritta nel fondo dorato della
divinità, ha anche una bella e lavorata aureola dorata, come anche il Figlio. Le
due aureole che s'intrecciano sono anche segno di comunione nel mistero divino.
La Vergine Maria è presentata rivestita di un ricco manto o omophorion che copre
il suo capo e scende come una tenda sulle sue spalle. La ricopre per intero,
come per intero è ricoperta dalla grazia Colei che è Tuttasanta. La veste
interna della Vergine è rosso porpora e significa l'azione dello Spirito Santo
che la riveste per intero, dal capo ai piedi. Spunta il colore rosso sul suo
capo e sulle sue maniche eleganti da Regina. Fino a confondersi come parte del
vestito di Maria e del vestito del Bambino.
Il colore azzurro della veste esprime la realtà celeste. Lo troviamo spesso nel
manto del Cristo Pantocratore e in alcune icone della Vergine Maria, con una
tonalità soave e leggera. Il colore rosso lo si trova spesso nella porpora delle
vesti del Cristo Pantocratore. Ma anche della Vergine Maria, come nella nostra
icona, dove Maria appare rivestita completamente dell'amore e della santità
dello Spirito, il Panaghion, il Tutto santo che rende Maria la Panaghia, la
Tutta Santa o Santissima. Maria appare nella sua bellezza e compostezza. Non è
una dea, è una donna, una madre, una nostra sorella. Il suo volto è bello,
proporzionato: occhi grandi e profondi, naso affilato, bocca piccola. Il suo
capo coperto è ampio, come sede della sapienza, elegantemente ricoperto con la
parte superiore dell'omophorion. Il collo è forte e sottile, come torre di
avorio, turris eburnea. Le sue mani sono ampie e le sue dita sottili. Sul lato
destro del manto di Maria una stella, allusiva anche alle tradizionali tré
stelle sul capo, e a destra e sinistra del suo vestito, all'altezza delle sue
spalle. Segni antichi della sua verginità, prima, durante, dopo il parto. Il suo
volto, raccolto e bello, illuminato, con gli occhi che guardano dentro al
mistero, ma anche che guardano noi. È la Tota pulchra. Maria porta accanto a sé
il Bambino Gesù che è insieme un Bambino m che traduce anche qualcosa di adulto
nelle sue sembianze. E "l'antico dei giorni", il Figlio del Padre eterno.
Esisteva già nell'eternità prima di esistere nel tempo. Con le sue mani Maria lo
stringe soavemente a sé, per significare insieme la comunione materna e filiale,
la tenerezza. Anche il volto del Bambino rispecchia le caratteristiche dell'iconografìa
orientale: capo ampio con una bella capigliatura che prelude le belle immagini
di ondeggiante chioma di capelli del Pantocrator nelle icone cretesi, bulgare e
russe. Piccoli sono gli occhi, il naso, l'orecchio. La tenerezza dell'intima
comunione si manifesta nel dettaglio comune delle icone, con le guance del
fanciullo che si fondono con quella della Madre. Così si rappresenta la
comunione intima della Madre col Figlio, anche nelle icone della deposizione
dalla croce, o della Madre di Dio con il suo Figlio morto nella sepoltura. Una
intimità indistruttibile. Il Bambino accarezza la Madre soavemente sotto il
mento con la mano destra, mentre si aggrappa al suo vestito con la sinistra e un
ginocchio si appoggia sulla Madre. Il Figlio guarda lontano. Il suo sguardo si
perde nel mistero. Guarda a noi e guarda anche al suo lontano destino di
passione e di gloria. È l'immagine estetica della divina maternità, della Madre
e del Figlio. L'iconografo oltre ad esprimere la comunione della Madre con il
Figlio nella mutua carezza, ci rivela questa comunione, questa somiglianzà
divina fra il Figlio e la Madre, nell'identità delle sembianze, nello stesso
colore rosso del manto del Bambino che è anche manto della Madre. Ma vi è anche
un dettaglio importante. Il vestito del Bambino, una specie di camicia che fa
vedere il braccio e la mano, ha lo stesso colore della carne della Vergine Maria.
In realtà egli ha rivestito la nostra carne nella carne di Maria. Si realizza in
quest'icona una comunione che in una icona del Monte Athos si manifesta al
rovescio. Infatti in un'icona della Passione, della Madre accanto al Figlio
morto, il vestito di Maria ha lo stesso colore della carne del Figlio. In quest'icona
il vestito del Figlio ha lo stesso colore della carne della Madre. Maria è
simile al suo Figlio come il Figlio è simile alla Madre, di cui ha presso la
nostra carne, la nostra natura umana.
L'insieme dei loro volti rispecchia l'iconografia classica secondo alcune
caratteristiche che troviamo nei manuali di iconografia che interpretano alcuni
elementi estetici. Secondo l'iconografia classica i personaggi delle icone
posseggono una maestà ieratica. Sono quasi una terza forma di bellezza tra la
fotografia ed il linguaggio astratto. In genere, come nel nostro caso, sono
vestiti con estrema eleganza, secondo lo stile bizantino; le figure sono snelle,
i lineamenti illuminati, la fronte ampia, gli occhi profondi, le orecchie
attente. Offrono sempre il volto, senza profili, poiché l'assenza di una
presentazione frontale costituisce un modo ingannevole di presentarsi. Tutto il
messaggio sta nel volto, dove si scopre l'immagine di Dio nell'uomo. I
personaggi sono figure ieratiche, immobili, come chi contempla o si lascia
contemplare. La loro carnagione non ha mai il colore naturale ma un colore
oscuro. E quasi una trasfigurazione della natura umana che annuncia la
resurrezione dai morti. Una Presentazione dell'esposizione delle icone del
Vaticano, dal dicembre del 1989 al gennaio del 1990, descrive così l'estetica
dell'icona che si concentra nei volti: "II centro della rappresentazione è
sempre il volto; è il luogo della presenza dello spirito di Dio, perché la testa
è la sede dell'intelligenza e della sapienza. Il volto è costruito intorno a tré
cerchi: il primo, normalmente dorato, contiene l'aureola, simbolo della gloria
di Dio; il secondo comprende la testa e in essa compare la fronte, sede della
sapienza, molto alta e convessa, in modo che appaia la forza dello Spirito; il
terzo cerchio comprende la parte sensuale del volto ed esprime la natura umana
della quale il personaggio raffigurato si è rivestito durante la sua vita. Gli
occhi, il cui sguardo si irradia verso lo spettatore e tiene concentrata tutta
l'attenzione, sono grandi, fissi e severi, sono incorniciati in ampie
sopracciglie ad arcate. Le narici sono sottili, vibranti sotto il movimento del
soffio dello Spirito, e manifestano l'amore appassionato per Dio. La bocca è
piccola, talora è disegnata in forma geometrica ed è sempre chiusa, quasi nel
silenzio della contemplazione".5 E a proposito delle icone della Madre di Dio si
affermano alcuni particolari che noi pure possiamo osservare nella Bruna di
Napoli: "Osservando le icone della Madre di Dio si può notare la rotondila del
capo della Vergine, che indica la perfezione della creatura scelta da Dio per la
realizzazione del suo disegno salvifico sull'uomo. Anche le mani, nella loro
stessa forma nobile e allungata, rivelano profondi significati teologici.Vale
la pena in questo momento ascoltare due testi importanti sull'immagine di Maria,
contemplando anche l'immagine della Bruna. Uno appartiene all'alta tradizione
patristica greca e risale a S. Epifanie di Salamina. L'altro di un Manuale di
iconografia del Monte Athos, di vari secoli posteriore alla nostra immagine.
Niceforo Callisto (sec. VIII-IX) in un testo che già fu citato alla fine del
seicento da un frate carmelitano, Filocalo Caputo, a proposito dell'icona della
Bruna riferisce la testimonianza di S. Epifanie circa il volto di Maria e
afferma: "La Vergine non era di alta statura, benché alcuni dicano che
sorpassasse il limite della media...Il colorito leggermente dorato dal sole
della patria sua, rifletteva il colore del frumento. Biondi i capelli, vivaci
gli occhi, un po' olivastra la pupilla. Le sopracciglia arquate e nere: il naso
un poco allungato; le labbra rosse e colme di soavità nel parlare, il viso ne
tondeggiante ne aguzzo, ma leggermente ovale, le mani e le ditta affusolate." 7
II Manuale di iconografa dell'ottocento, di Dionisio da Fuma, monaco
del Monte Athos, indica il modo di dipingere l'icona della Madre di Dio e ci
trasmette della sua figura questi dettagli che ben si possono contemplare
nell'immagine della Bruna. Maria, si dice, aveva la carnagione "del colore del
grano, con cappelli biondi e occhi chiari e belli, sopracciglia allungate, naso
medio, mano lunga con dita affilate..."8 Maria appare anche nella sua bellezza
tipica intcriore ed esteriore. È stato detto a proposito di Maria da parte del
grande Patriarca Atenagora I: "La Madre di Dio è ad un tempo sapienza e
bellezza. In lei si raduna tutta la bellezza della creazione per partecipare
alla bellezza divina."9
5. UNA LETTURA TEOLOGICO-SPIRITUALE
Ogni immagine porta il suo significato nel suo nome iscritto nella tavola
iconica. Il nome è la persona, la realtà. Si intravede nell'icona della Bruna il
nome della Madre e del Figlio con le classiche iniziali in lingua greca: Meter
Theou, lesous Christos, Madre di Dio, Gesù Cristo.
Il nome più essenziale è Maria, personaggio unico ed irrepetibile; il titolo che
racchiude tutto il mistero e tutta la missione di Maria è quello di Theotokos ,
Madre di Dio. L'icona della Bruna è l'icona della divina maternità di Maria.
Questa icona rende viva la storia stessa di Maria, traduce in colori la Parola
evangelica. Quella che si riferisce in genere al titolo di Madre di Gesù. Titolo
dato dall'Angelo, da Elisabetta, da Gesù, dagli apostoli, dalla Chiesa... Ci
rivela l'esperienza concreta della sua maternità, il suo portare il Figlio
piccolo sulle sua braccia, allattarlo, presentarlo ai pastori, a Simeone, ai
Magi. Il cammino di Egitto con il piccolo raccolto nelle sua braccia. Il suo
sguardo traduce le parole di Luca, dopo la nascita di Gesù e i primi episodi
dell'infanzia: "Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel
suo cuore..." ( Le 2,19), mentre osservava la misteriosa crescita del suo
Figlio: "II bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di
Dio era sopra di lui" (Le 2,39) a un certo punto Maria non porterà più Gesù
sulle sua braccia, finché alla fine della vita, deposto dalla croce lo
accoglierà di nuovo. Desolata, sulle sue ginocchia. Forse anche nell'icona della
Bruna Maria, come nell'icona della Madre di Dio di Vladimir e in quella della
Passione o del Perpetuo Soccorso, guarda lontano a questo misterioso traguardo
che la rende pensosa ed insieme disposta a compiere fino in fondo la sua
missione. Il centro dell'icona, e quindi il centro stesso della Vergine Madre, è
costituito dalla figura di Gesù, l'Emanuele, il Dio con noi, secondo la profezia
di Isaia. Maria è insieme Madre di Dio e Portatrice di Dio. La Madre sostiene il
Figlio in un abbraccio, con le due mani: Maria è la Theophora e l'Odighitria ,
portatrice di Dio, Colei che indica la strada. La divina maternità di Maria
esprime non tanto e non solo il privilegio mariano eccelso di una donna
diventata Madre di Dio, ma di una donna che proclama che il suo Figlio è il
Figlio di Dio. La storia della salvezza è un mistero, un sacramento, un progetto
di Dio che si svela e si realizza nel tempo e che ha come centro il mistero di
Cristo. Il Padre lo ha svelato con una logica sapiente. Lo ha realizzato, in
mezzo alle contraddizioni della storia degli uomini, riportando continuamente le
cose al suo disegno originale. Cristo è la chiave di volta di questo disegno di
salvezza ed è la segreta sorgente di luce che illumina il mistero di Maria dalla
Genesi all'Apocalisse. Senza questa sorgente nascosta, non si possono scoprire
tante armonie e tante anticipazioni di Maria nelle vicissitudini dell'Antico
Testamento. Senza una visione grandiosa delle "meraviglie di Dio" con il suo
Popolo, saremmo anche noi tentati di ridurre Maria ad una piccola, povera e
sconosciuta donna del popolo che ha dato i natali al Messia. La grandezza di
Maria invece non fa altro che riflettere la grandezza del Dio della creazione,
del Dio dell'esodo pasquale e della nuova Alleanza. Perché non dovrebbe essere
grande Dio nei suoi doni verso Maria se è stato grande nelle meraviglie operate
nel suo popolo? Allora anche la visione di fede che progetta su Maria la
pienezza della grazia, la verginità e la maternità, hanno la loro logica divina;
sono le grandi cose che il Dio della storia della salvezza ha operato in lei, in
vista del momento culminante, atteso e preparato che è l'incarnazione del Verbo.
Maria ritrova la sua chiave di comprensione nel mistero del Figlio, Salvatore e
Redentore. Egli è la vera luce che illumina il suo mistero, colui che svela
Maria all'umanità ed anche a se stessa. Troviamo quindi una assoluta inclusione
di Maria nel mistero di Cristo e pertanto una assoluta relatività di Maria al
servizio di questo mistero. Ma non dobbiamo dimenticare che è Dio stesso che ha
voluto il necessario passaggio del Verbo per il grembo di Maria. Non ha
affiancato Maria a Cristo, ma ha voluto Cristo nato dalla Vergine Maria. In un
certo senso è lei, la Madre del Verbo Incarnato, che ha svelato a noi il mistero
del Figlio eterno del Padre. Con la sua maternità lo ha reso immagine di Dio
nella nostra umanità, parola, volto, amore. Non è esagerato affermare che Maria
ha "umanizzato" Dio. Lo ha reso, per volontà stessa dell'Altissimo, uomo con
tutte le conseguenze. Maria ci ricorda così che la salvezza di Dio è salvezza
nella carne, salvezza incarnata. Maria non è una semplice Madre nell'ordine
fisico ed ontologico della maternità; è Madre a partire dal suo libero consenso;
la sua maternità che è insieme fìsica, psicologica, spirituale, diventa
principio di comunione e di destino con la persona e l'opera del Figlio in un
cammino progressivo di donazione. Qual è allora il senso dell'icona della
Theotókos con il Figlio suo fra le braccia? Maria proclama la fede della Chiesa
nella vera umanità di Cristo e nella sua divinità. Ci rassicura della verità
dell'incarnazione che è fondamentale nel modo di percepire la salvezza. Dio si è
fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Egli non ci ha salvato soltanto attraverso
i messaggi di una dottrina altissima, ma mescolandosi con la nostra natura,
assumendo nel Figlio quello che è nostro per salvarlo. L'incarnazione, nella
quale Maria ha avuto un ruolo specificamente materno, è la vera comunione di Dio
con l'uomo; è la chiamata dell'uomo a condividere la comunione con Dio. La
particolare accentuazione del mistero di Maria come Vergine della tenerezza,
dell'amore tenero e materno, offre ai nostri occhi anche un'immagine della
tenerezza materna del nostro Dio che si rivela nel volto materno della Madre. Si
tratta di una tenerezza misericordiosa, di una compartecipazione alla vicenda
del suo Figlio. Ma nella maternità di Maria che ci mostra Cristo, l'unico
Salvatore, possiamo anche scorgere l'immagine del Primogenito che rimanda a
tutti i suoi fratelli. Ieri Cristo, oggi la Chiesa, ieri il Figlio di Dio, ora
noi, i figli di Dio. Per questo l'icona della Bruna è insieme un'immagine della
tenerezza della Madre di Dio verso il suo Figlio e verso i suoi figli. È icona
della Madre di Cristo, icona della Madre dei fedeli. Nel suo sguardo misterioso
si proietta la sua tenerezza verso tutti. E nei suoi occhi pieni di soave
dolcezza i fedeli scoprono la Madre tenera e misericordiosa di tutti.
UNA
PREGHIERA DAVANTI ALL'ICONA
Davanti
all'icona della Bruna ci piace sostare in preghiera e ridire alla Vergine del
Carmelo, guardando la sua icona materna, le parole di un Carmelitano della
Spagna, Jaime Montanés : "Oh Vergine Santissima, Madre del Creatore e Salvatore
del mondo, avvocata dei peccatori! E giusto che, dopo aver reso grazie a Gesù
Cristo tuo Figlio e mio Redentore, per essersi dato con amore per me peccatore,
e per avermi comunicato il suo santissimo copro, io dia grazia anche a tè,
celeste Regina, perché da tè prese l'umanità questo Verbo divino, tuo Figlio e
mio Dio e Creatore. Con umiltà supplico la tua clemenza, perché sei Regina del
cielo e madre della misericordia e di questo misericordioso Signore e - poiché
dalla pienezza della tua grazia i prigionieri ricevono redenzione, gli afflitti
consolazione, i peccatori perdono dei loro peccati, i giusti grazia e gloria,
gli infermi salute e gli angeli una grande gloria - ti supplico di comunicarmi
la tua benevolenza, o Signora e Madre della stessa grazia e misericordia. Tu o
Signora sei la scala del cielo, la stella del mare, la porta del paradiso, la
sposa del Padre eterno, la madre del Figlio e il tabernacolo dello Spirito
Santo, sigillata dal Padre con la sua potenza, dal Figlio con la sua saggezza e
dallo Spirito Santo con la sua bontà ".10
P. JESÙS CASTELLANO CERVERA OCD.
NAPOLI, 29 OTTOBRE 2000
ANNO GìUBÌLARE XI
Note :
7 NICEFORO CALLISTO,
Storia della Chiesa, libro II, cap. 23: PG 145, 815-816;
Cfr. G. MONACO, O.C., p. li'-29, con la descrizione del volto di Maria.
8 Ermeneutica della pittura. Napoli 1971, p. 305.
9 O. CLÉMENT, Dialoghi con Atenagora, Torino, Gribaudi, 1972, p. 306.
10 Citato da E.
BOAGA, Con Maria nelle vie di Dio. Antologia della marianità carmelitana. Roma,
Edizioni Carmelitane, 2000, p. 100.
Fonte: www.santuariocarminemaggiore.it